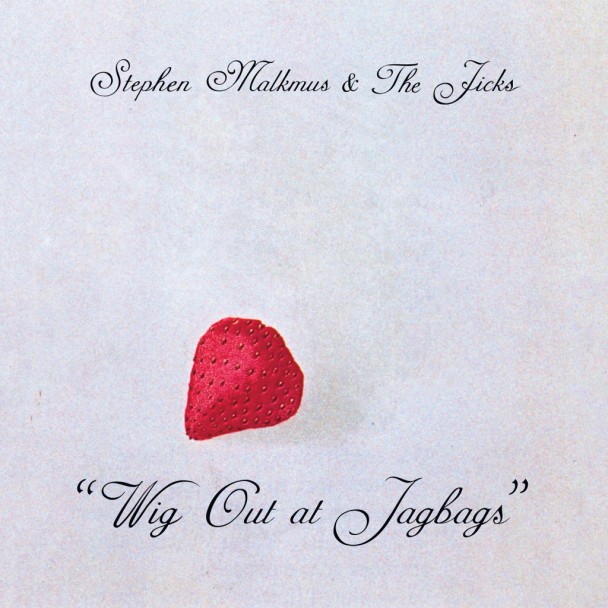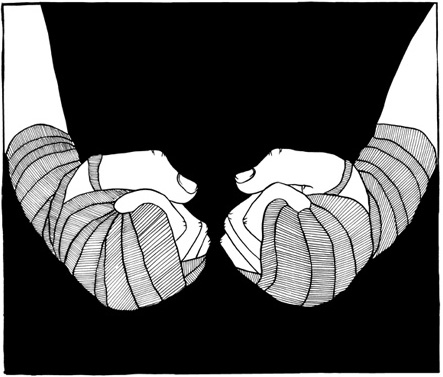A 14 anni mi hanno detto che non potevo andare a vedere i Pavement perché ero troppo piccolo. Poi c’è stata tutta la carriera dei Pavement durante la quale ero proprio nell’età giusta per andare ai loro concerti e saltellare, infatti l’ho fatto. Nel frattempo, cioè tra adesso e la fine dei Pavement e la reunion dal vivo, Stephen Malkmus ha fatto un po’ di dischi da solo. E a 35 anni vado a vederlo al Covo, per il tour di Wig Out At Jagbags, dopo tre anni che non fa un disco. E mi dicono cosa vai a fare, io quello non l’ascolto più da un pezzo. Sono quindi ritornato ad avere un’età inadatta per lui. Ma tornare a vederlo è come andare al mare la prima volta dopo tutto l’inverno. Quindi, fanculo.
Arrivo a Bologna da Bolzano, dove sono stato a una fiera di edilizia, cioè a venerare l’unico dio della mia terra, il mattone, il che significa che arrivo al concerto che di anni ne ho almeno 50, dentro. Sapete, no, che Malkmus una volta ha ironizzato su Kurt Cobain per il fatto che voleva chiamare In Utero I Hate Myself and I Want to Die. 2 anni è durato Kurt Cobain da quando Malkmus è uscito col primo disco coi Pavement. Nel senso che poi si è ucciso. Malkmus e Kurt Cobain sono due cose diverse successe nello stesso decennio e convivono nel cuore di un sacco di gente. Io non ho mai visto Cobain dal vivo, Malkmus lo volevo perdere anche se sono diventato grande, perché, a giudicare da Wig Out At Jagbags, ero sicuro che sarebbe stato una specie di simpatico schivo animale musicale che gioca con le canzoni come nessun altro, come ci giocava una volta, ed ero sicuro che avrei rivisto sul palco almeno una parte degli anni 90. Non so perché mi è venuto in mente di fare questo confronto, anche perché di “parti” negli anni 90 ce ne sono molte, ma l’altra parte (Cobain) non è più possibile vederla. Così, per contrastare una mancanza, non mi sono perso quello che è possibile vedere.
Malkmus secondo me è l’espressione più alta di una grande invenzione, il rock indipendente americano partito spacciandosi per storto per poi assumere col tempo una forma più dritta pur conservando sempre un po’ quell’atteggiamento di sfida nei confronti dei tecnicismi, che pure ci sono. E questo rock indipendente americano partito spacciandosi per storto per poi assumere col tempo una forma più dritta pur conservando sempre un po’ quell’atteggiamento di sfida nei confronti dei tecnicismi è proprio un genere eh.
Insomma vedo Stephen Malkmus coi Jicks dal vivo e capisco – quest’anno ancor più che coi Pavement, perché il contrasto con i mattoni mi ha portato così lontano dai mattoni che mi ha permesso di concentrarmi ancora di più sul concerto, come quando in un momento preciso apprezzi tantissimo una cosa perchè è l’opposto di qualcos’altro che non ti piace tanto, come prima per Kurt Cobain – che è un chitarrista mostruoso al limite pornografico del Prog e dello Psych rock e che i musicisti che si è scelto compongono una tra le migliori band viste dal vivo negli ultimi anni.
Continuare a ragionare per opposti potrebbe essere fuorviante: non mi piacciono Malkmus & The Jicks solo perché sono quello che rimane dopo Kurt Cobain e il mattone, ma soprattutto per tutto il resto.
Quindi. Quando mi trovo più o meno di fronte al palco, mi giro e vedo gente che non ho mai visto alzare il braccio e cantare, per esempio mio fratello, provo l’incredibile, e non so se sono a un concerto di Vasco oppure no, ma sono in bolgia. (Mio fratello ascolta Vasco, un po’ gli piace, il famigerato primo Vasco, ma non l’ha mai visto dal vivo, e lo ascolta solo su Spotify, non ha mai comprato dischi suoi.) Ma il bello è che sembriamo a un concerto di Vasco e sul palco grazie a dio non c’è Vasco, c’è Malkmus. Io l’età, in questi casi, non la prendo neanche in considerazione; chi era a vedere Malkmus a Bologna ha visto quattro musicisti cazzutissimi mettere in piedi un’ora e mezza di musica che potrebbe ascoltare anche per sempre e presentare un disco tanto allineato al passato quanto no, una cosa così figa da farmi pensare che fosse la più figa. Wig Out At Jagbags non tradisce nessuna aspettativa. Questo non significa dare un colpo al cerchio e uno alla botte, ma riuscire a rispondere alle esigenze di chi ascolta, sia a quelle che spingono a desiderare di sentire quello che ti piacerà perché ti è già piaciuto, sia quelle che ti fanno desiderare qualcosa di nuovo. Oppure significa creare esigenze musicali nuove, perché io ricordo che da Malkmus mi aspettavo un bel disco alla Malkmus e nient’altro. Sapete quando pensate ai pilastri che non possono crollare, ne siete sicuri, e in effetti non crollano. Malkmus è uno di quelli; ha superato tutti gli anni 90 ed è arrivato ad ADESSO come se niente fosse, sul disco, e sul palco. Sul palco mostra distacco e grande professionalità. Allo stesso tempo è chiaro che si diverte un sacco; più o meno è una macchina che sputa canzoni con una semplicità e una precisione sorprendenti, e una specie di smania più forte di lui, e tira la fila di una band che funziona a perfezione, anche a cazzeggiare. Sul disco controlla tutto, usa la chitarra come strumento di comando: tranquillizza e tiene legati a se gli altri strumenti che tendono a scappare (Planetary Motion), chiude un discorso (The Jenitor Revealed) oppure fa casino con gli altri (Houston Hades). Il suo modo di scrivere è sorprendente, come se le canzoni gli uscissero così, senza fatica, con quei cambi di suoni e tempi, con quelle dilatazioni contrapposte alle ritmiche più pop, con quelle linee vocali. L’inquietudine si sente, nel modo frenetico che ha di arrangiare. Secondo me, se prendiamo un mattone e sopra ci mettiamo una foto di Kurt Cobain abbiamo tutto quello che c’è dentro a Stephen Malkmus adesso: una certa stabilità e quel non so che di irrequieto.
Perché ha perso Di Caprio e non McConaughey
Visto che è una sfida che mi sono preso non so neanch’io perché molto a cuore, vorrei chiarire i motivi per cui secondo me Leonardo Di Caprio non ha vinto l’Oscar come miglior attore protagonista e invece Matthew McConaughey si.
In un articolo su Wired.it Gabriele Niola spiega perchè un film vince l’Oscar: di base il concetto è farsi vedere da più giurati possibile, quindi promuovere il film organizzando per loro feste e buffet. Pochi giurati vedono tutti i film, molti votano scegliendo tra quelli che hanno visto, molti ne vedono solo uno, quindi farsi vedere è appunto fondamentale. Il discorso di Niola vale, e lui lo scrive, soprattutto per una categoria come il Miglior Film Straniero perchè è più facile che i giurati vedano le grandi produzioni in gara piuttosto che il piccolo film kazako. Per la scelta del Miglior attore possono considerarsi valide le stesse considerazioni: vedi un film, decidi se è più bello di un altro, decidi se un attore è più bravo di un altro, più l’attore si fa vedere, maggiori sono le possibilità che vinca. Se un giurato ha visto solo un film, vota l’attore di quel film. Che metodo di merda. L’Oscar è un Premio molto poco attendibile. Già.
Al netto di tutti i discorsi sui diritti civili degli omosessuali, l’AIDS, che sono temi FONDAMENTALI, i dimagrimenti, gli a Scorsese non danno mai l’Oscar, a Di Caprio neanche e l’Academy non premia mai i migliori, il suo è un giudizio condizionato da cose extra-filmiche, rimane la prova dell’attore, che io posso giudicare esattamente come se fossi uno dei giurati seri, scegliendo, dopo aver scremato, tra le due prove migliori. Ecco i tre motivi per cui secondo me Woodroof-McConaughey ha vinto conto Di Caprio-Belfort.
1) Ne ho già parlato con wwayne in alcuni commenti. Di Caprio è di sicuro uno dei più grandi attori in circolazione, tutti lo amano, anch’io. Ma ha perso la caratteristica che aveva un po’ di tempo fa, per esempio in Romeo e Giulietta e The Beach, in cui sulla scena c’era il personaggio. Da quando è diventato grande, Leo dà sempre più spazio alle proprie caratteristiche e non riesce a concederne abbastanza al personaggio che interpreta; è molto espressivo, ma l’espressività e la fisicità sono sue, non del personaggio. McConaughey ha fatto il contrario, in Dallas Buyers Club è dietro al personaggio, non davanti.
2) Jordan Belfort percorre una strada meno tortuosa rispetto a Ron Woodroof, che è un personaggio più complesso. Woodroof parte da una serie di certezze che all’inizio non sembrano neanche scalfibili e alla fine cambia visione della realtà (un po’). In mezzo c’è la presa di coscienza della malattia, il tentativo di combatterla per vie tradizionali, la ricerca di una via alternativa, l’idea di aiutare anche le altre persone, l’amicizia con un travestito, il confronto con la vecchia vita e le vecchie idee, la lotta per difendersi dall Stato e anche altre cose tra le quali il dolore fisico. Jordan Belfort è sempre in ascesa, sempre padrone degli altri e di se stesso, si rende conti dei pericoli economici e affettivi che corre ma decide che quello che deve fare è quello che ha sempre fatto. L’arco psicologico lungo il quale si muove Woodroof è più ampio rispetto a quello di Belfort. Il personaggio è scritto nella sceneggiatura, la sceneggiatura può essere più o meno di ferro, l’attore può più o meno farsi guidare dal regista. Ma il risultato è l’interpretazione del personaggio, ed è l’interpretazione che va premiata oppure no. E arrivo al motivo n.3.
3) Il premio va al personaggio, e all’attore che interpreta il personaggio, non all’attore o al personaggio. Quindi non è che Di Caprio doveva vincere perché non ha mai vinto o McConaughey non doveva vincere perché è forse la sua prima interpretazione a questo livello. C’è l’attimo dell’ispirazione, che immagino per un attore possa arrivare quando una serie di cose coincidono, quando la storia lo convince molto, quando s’instaura un buon legame col regista e col cast e per tutta una serie di altre cose che posso solo ipotizzare. Tutto è andato per il verso giusto a McConaughey; Di Caprio, di fronte all’ennesimo personaggio enorme, cioè magniloquente (da J. Edgar in poi, sempre), ha adottato il suo standard e ha looppato la prestazione con lievi sfumature. Sarebbe utile cambiare tipologia di personaggio, per ritrovare l’ispirazione di Titanic, Buon compleanno Mr. Grape oppure, boh, Celebrity. Una cosa ingenua, ma interpretando sempre grandissimi personaggi forse Leo ha perso un po’ la misura, la sensibilità, l’obiettivo, e si è concentrato troppo sul se stesso che interpreta un grande personaggio e non sul personaggio che, se scritto bene, deve mettere in mostra il più possibile le proprie caratteristiche. Credo che la difficoltà del mestiere stia anche qui: nel dare un volto e un’espressione all’animo del personaggio; quanto più più l’animo è complesso, tanto più l’interpretazione è difficile; quanto più l’interpretazione è difficile, tanto più l’attore deve fare la prova della vita. Non ho visto niente di tutto questo in Di Caprio e Belfort, neanche rivedendo certe scene in lingua originale. E magari è un problema che nasce nel personaggio così come è stato scrittto, così come è stato in realtà.
Non so perché ma non mi aspettavo quel discorso da Matthew McConaughey alla cerimonia, una specie di improvement diocentrico della stima di se stesso. Quasi nessuno fa discorsi significativi all’Oscar, ma il suo è stato particolarmente frangipalle. Di Caprio, non sapendo cosa fare per salvare l’etichetta, annuiva ma non voleva farlo. Quel discorso mi ha fatto ricordare che comunque McConaughey è l’interprete di Sahara e di Magic Mike, lo è proprio dentro, un muscoloso attore americano. Tutti ci hanno venduto il sogno americano l’altra sera, ma lui è stato più profondo, l’ha arricchito di considerazioni sul fatto che Dio e se stesso sono stati le sue due fonti di ispirazione. Ce n’era una terza ma adesso non me la ricordo, forse la mamma. Bello perché un discorso così strideva con il fatto che era sul palcoscenico per Dallas Buyers Club, che avevo interpretato come il desiderio di alzare il livello della propria cinematografia. Però McConaughey ha interpretato un malato di AIDS, cosa per la quale il mondo si è preso benissimo, e cosa perfettamente in linea con il personaggio apparso sul palco l’altra sera, molto politicamente corretto; è anche l’attore di Mud e del prossimo film di Christopher Nolan, che non è noto per fare delle cagate. Non faccio confusione tra attore e personaggio, dal momento che quella sera quasi tutti sono personaggi, non proprio magari i personaggi che hanno interpretato, ma personaggi. Sono solo un po’ confuso riguardo alla personalità professionale di McConaughey; non me l’aspettavo ma devo considerarlo imprevedibile. Cosa che non posso fare con Di Caprio di cui ho UN’idea, che è poi quella che ha Scorsese.
il disegno è di Andrea Plazzi
(A proposito di Davis) Si, mi piacciono i gatti, però
 l’unico sketch brillante di un film dei Coen non può essere quello del gattino smarrito. Se non avete visto A proposito di Davis (Inside Llewyn Davis) la storia bisogna che ve la racconti, è molto semplice: c’è un musicista folk (Llewyn Davis) che nel ’61 a New York, più o meno al Greenwich Village, non riesce a sfondare; per questo motivo è depresso. In più, è molto sfortunato. E basta.
l’unico sketch brillante di un film dei Coen non può essere quello del gattino smarrito. Se non avete visto A proposito di Davis (Inside Llewyn Davis) la storia bisogna che ve la racconti, è molto semplice: c’è un musicista folk (Llewyn Davis) che nel ’61 a New York, più o meno al Greenwich Village, non riesce a sfondare; per questo motivo è depresso. In più, è molto sfortunato. E basta.
Uno dei simboli della sfortuna di Davis è un gattino di amici, che scappa di casa, e che a un certo punto è l’unico essere vivente a cui rimane aggrappato, sigh. Poi Davis decide di smettere di suonare ma non riesce a fare neanche quello. Sembra una storia triste, ma Davis fa fatica anche ad apparire triste, perché è troppo stanco. E non è una cosa positiva, anche perché la conseguenza è che la sua storia è debole, anzi noiosa. Si concentra sul gatto, sui figli non riconosciuti, sul rapporto con la ragazza di un amico e con la sorella; cioè parliamo più o meno sempre di lui e molto poco della musica e del Greewich Village. Quindi A proposito di Davis non è un film sulla musica ma su un personaggio, è chiaro fin dal titolo; ed è quanto meno ambiguo fare trailer (almeno uno dei) includendo la canzone di Bob Dylan, che nel film arriva alla fine e nei titoli di coda. Quella canzone e il contesto evocato, con tanto di locandina italiana (almeno una delle) in memoria di The Freewheelin’, tocca un determinato immaginario, che poi nel film c’è in minima parte. E molti l’hanno presentato così, molti della stampa, come un film sul folk. Gomblotto! È un film su un cantante folk che avrebbe potuto essere anche un pittore per quanto è importante il folk, e al posto del locale in cui suona avrebbe potuto esserci uno studio sui tetti di Parigi. Ma tengo per buono che sia un musicista. Comunque non è bravo abbastanza da diventare famoso. Non si ammette neanche questo, nel senso che si abbozza ma non si percorre la strada del non è abbastanza bravo, e si ricorre all’è un musicista che vuole fare la sua musica, non vuole scendere a compromessi per questo non ha successo. E così ripartiamo con la centesima pippa sull’artista puro e anche un po’ incompreso, pippa che (ok) si mescola con una certa inettitudine, ma l’intenzione è quella di raccontare un incompreso. Da tutti. Nessuno lo vuole, non ha famiglia, ha solo una sorella che lo odia perché è l’opposto di lui – e per questo è il controcanto più interessante del film -, non ha casa. È un barbone; e, dai, non è bello un film che parla di un barbone.
Poi c’è il gattino (Ulisse), protagonista di uno sketch sintomatico del livello (basso, rispetto alla media Coen) dei dialoghi e della sceneggiatura. Davis una sera dorme in casa di amici e uscendo fa uscire anche il gatto. Lo recupera, ma Ulisse scappa ancora. Seguono giorni interi a preoccuparsi di lui. Per puro culo Davis lo ritrova, lo riporta agli amici ma Ulisse non è Ulisse, è un altro gatto che gli assomiglia. Prevedibile, ma un po’ integrante. Per gli Ebrei il gatto è un animale selvatico pericoloso per l’uomo, ma viene tenuto in casa perché uccide i topi, e per questo va rispettato. Simbolicamente ha significati sia positivi che negativi. Comprendo che sia affascinante per i Coen l’idea di ribaltare la simbologia ebraica trasformando il gatto in un animale solo buono e bello (i gattari di tutto il mondo, toccati nella passione, sono giustamente corsi a vedere la storia di Davis), ma che mi incuriosisca vedere come si sviluppa una loro sceneggiatura solo per sapere che fine ha fatto il gatto visto che il resto della storia mi interessa poco mi sembra un segnale da interpretare negativamente. In più, questa recensione l’ho iniziata col gatto e l’ho finita col gatto, e io posso anche farlo, ma che i Coen aprano il film con una sequenza per poi riprenderla alla fine per dirmi che la vita di Davis non cambia mai è sintomatico di una chiara mancanza di idee. La circolarità è una soluzione abbastanza classica ed è stata un (odio la prossima parola ma non me ne vengono altre) escamotage piacevole in passato; ma non è più un elemento di sorpresa e utilizzarla per risollevare alla fine dei giochi i destini di una storia che non ha punti di forza è solo un tentativo non riuscito di rendere in qualche modo interessante una storia che non lo è.
Fotografia bellissima, ma solo quella. (Niente Oscar). Non è quasi mai possibile fare sempre film belli, i miracoli succedono ma non sempre; anche i lisci succedono, e A proposito di Davis è uno di quelli grossi.